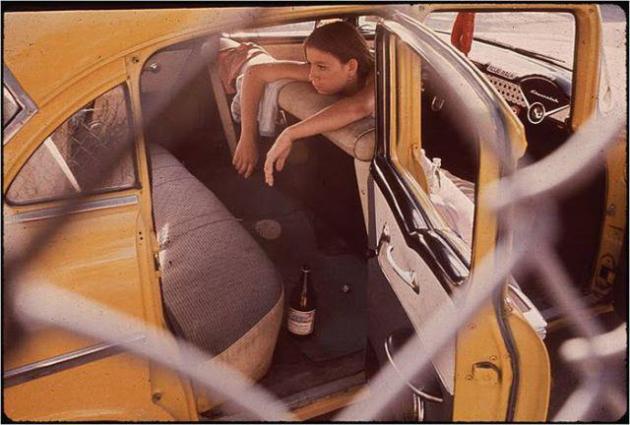L’altra sera ero impegnata per lavoro fuori città. Era un lavoro di poche ore, che tuttavia mi ha occupato praticamente tutta la giornata. Lo sapevo, mi ero preparata. Ciò nonostante la cosa che più mi preoccupava all’inizio riguardava gli spostamenti.
Ora, forse voi non lo sapete ma io sono una persona abbastanza fortunata: quando devo andare da qualche parte fuori città è molto probabile che non sia io a guidare. Semplicemente, lo fanno altri. Questa è una cosa piacevole, perché a me non piace molto guidare. L’altro lato della medaglia è che conosco molto poco le strade, tendo a perdermi facilmente, non presto attenzione a cartelli e segnali. Potete dunque immaginare quanto sia stata una sfida per la sottoscritta prendere l’auto per andare a fare questo lavoro senza nessuno a cui fare affidamento se non il mio navigatore che peraltro non è molto aggiornato. Il posto in cui dovevo andare non era neppure segnato sulla mappa, per dire. Alla fine comunque l’ho trovato e anche con grande facilità. Come sempre, le ansie che caratterizzano la mia vita non sono altro che giganti coi piedi di argilla, pronti a sciogliersi al primo passo. Basterebbe ricordarselo.
Perché racconto di questa cosa?
Perché quando la serata era ormai conclusa e stavo ormai guidando sulla via del ritorno, mentre stavo scivolando nella notte con le poche luci dell’autostrada e dei fari delle auto, ho provato una sensazione strana. La radio era accesa, ma a basso volume. Il finestrino un po’ abbassato, uno spiraglio d’aria.
Ciò che ho provato è stata una punta di felicità. È stato un attimo, davvero, poi è passato così com’è arrivato. Ho voluto allungare l’uscita dell’autostrada e ho proseguito per un po’ per continuare a riacciuffare quella cosa che mi aveva attraversato.
Ho percorso una galleria.
Solo io e la mia piccola macchina. La radio ha smesso temporaneamente di trasmettere, solo il rumore del motore, il mio respiro e la notte. Non so se scrivendolo qui si possa in qualche modo evocare, quel momento. Magari solo un’infinitesima parte. Ma mentre percorrevo la galleria mi sentivo come in quei film densi di metafore, quelli che piacciono a me per intenderci. Io, che scelgo di entrare nel tunnel, e a un certo punto non vedo più l’inizio né la fine, e sono dentro ma continuo ad andare avanti, perché so che a un certo punto finirà e rivedrò il mondo fuori, nonostante la sua notte.
È stato bello. Volevo ricordarlo.